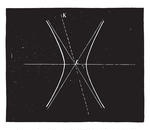Il primo re è un’opera coraggiosa, di forte impatto visivo, violenta e crudele ma mai autocompiaciuta, che porta a maturazione il percorso stilistico e artistico del regista, e che, anche al netto di alcune sbavature, non si può fare a meno di salutare come benefica.
Dopo averci divertito con la trilogia di Smetto quando voglio e stupito con Veloce come il vento, Matteo Rovere vira verso il cinema di genere e si cimenta con il mito fondativo delle origini di Roma. Un progetto ambizioso, certo, soprattutto perché impegnato fin da subito a smarcarsi sia dai canoni comico-folkroristici e talvolta perfino pecorecci dei film di genere degli anni ’70; sia soprattutto da quelli, assai più celebrati del peplum (I dieci comandamenti, Ben-Hur, solo per citare i più apprezzati), a cui il pubblico ha sempre tributato un grande successo.
Il primo re ha invece un respiro moderno. Guarda tanto al Revenant di Iñárritu quanto all’atmosfera primordiale e selvaggia di Malick (The new world ) e Winding Refn ( Valhalla Rising). La sfida è chiara: restituire la crudezza e il realismo che il mito sottrae alla storia, rivelandone così l’assoluta violenza e le insopportabili perdite che ne stanno a fondamento.
Travolti dalla piena del Tevere, Romolo e Remo cadono prigionieri della gente di Alba. Condotti alla città, vengono chiusi in gabbia e poi costretti, insieme ad altri prigionieri, a combattere l’uno contro l’altro nel pieno di un rito violento celebrato da un’enigmatica vestale. Grazie a un astuto stratagemma escogitato da Romolo riescono però a liberarsi e danno vita a una ribellione degli schiavi che li costringe a una fuga per la sopravvivenza. In questo viaggio, su richiesta di Romolo, portano con loro la vestale, custode del fuoco sacro agli dei. Braccati dai soldati di Alba, dovranno lottare anche contro la natura selvaggia e incontaminata del Lazio dell’VIII secolo A.C e farsi largo tra foreste abitate da spiriti e uomini brutali.
In questa discesa negli inferi della fame, della privazione e soprattutto della superstizione dei compagni, con un Romolo ferito e sofferente, si assiste all’ascesa di Remo, che da protettore amorevole del fratello assurge presto al rango di leader del gruppo e guida carismatica in battaglia. Una volta conquistato il villaggio dei nemici, però, il potere, l’orgoglio e l’avidità trasformano Remo in un tiranno che sfida sia gli dei che gli uomini. Così, una volta ripresosi dalle ferite, Romolo è costretto a scontrarsi con il fratello, ed entrambi maturano la consapevolezza, già rivelata dalla vestale tramite un rito aruspicino, che la volontà degli dei è a loro avversa, e che una grande città potrà nascere solo al terribile prezzo del fratricidio.

Il primo re: un’analisi
Che il peso più consistente del plot dovesse ricadere, in senso figurato o letterale, sulle spalle di Remo lo si poteva intuire già dall’abile campagna pubblicitaria firmata Groenlandia, tutta votata alla valorizzazione dell’attore italiano del momento: un Alessandro Borghi selvaggio, ferino, muscolare. A lui è demandato il compito di trasportare il fratello moribondo nella fuga verso la libertà, di procacciare il cibo nell’oscurità minacciosa della foresta ostile, di guidare il gruppo di sopravvissuti verso la promessa della sicurezza e la fondazione di una nuova città. Bisogna ammettere che Alessandro Borghi non tradisce le aspettative, aiutato dalla sapiente direzione fotografica di Daniele Ciprì, la cui scelta di girare sfruttando la luce naturale, contribuisce a restituirci un realismo impattante ma non estetizzante.

E’ una storia di uomini, prima di tutto, di carne e sangue, in cui gli spazi prosaici e romanzati sono ridotti all’osso. Vincente si è rivelata anche la scelta di utilizzare come idioma il proto-latino sottotitolato, quasi a voler scoraggiare una lettura del mito fondativo eccessivamente schiacciata sulla mitopoiesi e sull’eroismo del singolo e quindi poco o per nulla storica. C’è poi da considerare la dimensione prometeica ed epimeteica che informa la divergenza letale tra i due fratelli. A onor del vero la figura di Remo si costituisce più come un anti prometeo, stante che il fuoco sacro non viene sottratto agli dei per elargirlo agli uomini, quanto piuttosto usato contro di loro e poi spento, in un atto di sfida che però non viene portato a termine. Così la figura di Remo rientra nel solco della tragedia: il suo abbandono degli dei è sofferto e foriero d’imprevisti, guidato più dalla volontà di preservare il suo rapporto fraterno che non a sostituirsi alle divinità stesse, al contrario di quanto lo stesso Remo sia portato a credere. Mentre Romolo, (Alessio Lapice) rappresenta piuttosto l’epimeteo.

La loro è una differenza non solo caratteriale ma soprattutto politica: il fuoco degli dei è fondamentale per la gestione della comunità, crea solidarietà e unità laddove la forza e la paura invece, tendono a disgregare e creare conflitti. Sarà questa divergenza, assai rimarcata nel patrimonio mitopoietico e letterario, a costituire il casus belli e a trascinare i due fratelli verso l’avveramento della profezia. In questa lotta fratricida, a farne le spese è soprattutto la figura femminile della vestale Satnei (Tania Garribba), sacrificata, non solo fisicamente, al predominio fisico e caratteriale di Remo e alla saggezza devota di Romolo. Ottima è stata anche la scelta del cast, con attori realistici e credibili nelle vesti di proto-latini.

E infine il Tevere, vero convitato di pietra, presente nella scena iniziale (dal forte impatto visivo e realistico nonostante il ricorso alla computer graphic) e in quella finale. Quasi a simboleggiare il suo dominio e il suo ruolo archetipico di custode di un popolo condannato alla grandezza.
Alcune considerazioni
Il cinema italiano è vivo, vivissimo. A conferma di come la settima arte rappresenti una delle poche dimensioni capaci di proiettare il bel paese oltre i suoi confini insulari. Questo perché si è mostrato abile nello sfruttare il vasto repertorio artistico e letterario della sua storia evitando però di cadere vittima di codici estetici cristallizzati ancorché spacciati come peculiari della nostra tradizione. Oramai non esiste più solo il barocco moderno ed edonista dell’ormai acclamato premio Oscar Sorrentino, o il realismo asciutto e ostentato della conferma Garrone;Matteo Rovere si candida come outsider del cinema nostrano, mostrando ambizione e coraggio, misti a un pizzico di spregiudicatezza e volontà di sperimentazione.